
“Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità.” Questa riflessione dell’astronomo e divulgatore scientifico statunitense Carl Sagan, rappresenta la precarietà dell’essere umano, che vive pensando di essere immortale, fintanto che non interviene un evento drammatico o inatteso che mette in discussione la sua quotidianità e lo costringe a vedere il mondo con altri colori. Quattro anni fa questo pensiero si traduceva in una serie di eventi catastrofici a effetto domino generati da una anonima polmonite cinese (secondo fonti ufficiali). Nome di battaglia: Covid. La cronaca e le conseguenze di un fenomeno che sembrava isolato, ma che poi si è propagato a macchia d’olio in tutto il mondo, inarrestabile, potente, implacabile, è ormai storia. Una storia che ha preso, non lo possiamo negare, altre direzioni. Il progetto “Social Life during COVID-19”, che ha coinvolto sociologi francesi, tedeschi, italiani e inglesi, ha lavorato non sull’interrogativo “Quanto siamo cambiati”, ma piuttosto “se e dove siamo cambiati”.
La pandemia ha avuto un impatto profondo e duraturo sulle nostre vite, modificando il modo in cui interagiamo, lavoriamo e ci prendiamo cura di noi stessi e degli altri. Inizialmente, ci siamo trovati a dover affrontare l’incertezza e la paura, ma nel tempo abbiamo anche scoperto nuove risorse, che ci hanno aiutato a creare inedite modalità di connessione e resilienza. Molti di noi hanno sperimentato il lavoro da remoto, che ha trasformato le dinamiche professionali. Se da un lato ha portato a una maggiore flessibilità, dall’altro ha anche reso più difficile separare la vita lavorativa da quella personale.
Le relazioni sociali hanno subito un cambiamento significativo. Le restrizioni ci hanno costretti a rivalutare le nostre interazioni, portandoci a dare maggiore valore ai momenti trascorsi con le persone care, anche se virtualmente.
Inoltre, la pandemia ha messo in luce l’importanza della salute mentale, compromessa dallo stress e dall’ansia. Non ultimo, il Covid 19 ha evidenziato le disuguaglianze esistenti, portando a una riflessione su come diverse comunità vivono e preservano le loro tradizioni. La cooperazione internazionale è diventata fondamentale per affrontare la peste del nuovo millennio, e questo ha portato a una maggiore consapevolezza e apprezzamento delle diverse culture.
Molti eventi artistici e culturali, come concerti e mostre, sono stati trasmessi online, permettendo a un pubblico più ampio di partecipare, ma anche creando una certa distanza dalla tradizione di vivere queste esperienze di persona.
In un certo senso, la pandemia ci ha costretti a riconsiderare cosa significhi “cultura” e “identità”. Abbiamo iniziato a valorizzare di più le connessioni locali e le tradizioni, ma anche a esplorare come queste possano evolversi in un contesto globale. La cultura non è più solo qualcosa che si vive in un luogo specifico, ma è diventata un mosaico di esperienze condivise, che ci uniscono anche a distanza. ICCROM ovvero il Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, con sede a Roma, in un articolo dell’epoca sottolineava come le economie mondiali dovessero considerare la cultura una chiave di salvezza per risollevarsi e aggiungeva che “Al contempo, è sempre più evidente che la cultura è fonte di benessere per gli individui. Lo dimostra il numero crescente di eventi culturali e di tour virtuali proposti online per intrattenere e portar conforto alle persone isolate”. Uno studio condotto da “Better policies for life” parla di “shock cultura” ovvero di una digitalizzazione accelerata che ha sovvertito per sempre le modalità di fruizione della cultura e degli eventi culturali, oltre ad aver dato un nuovo e pericoloso volto all’istruzione (tiranneggiata da visori e strategie didattiche inedite). Se, da un lato, il ricorso alla digitalizzazione ha permesso all’umanità tutta di assaporare la bellezza della cultura condivisa, dall’altro ha avuto una ricaduta economica e sociale senza precedenti. Studi recenti e diffusi sottolineano come per andare avanti occorra “tornare un po’ indietro”: il digitale deve migliorare le nostre vite, non diventare la nostra vita.
Maria Elisa Stagnari
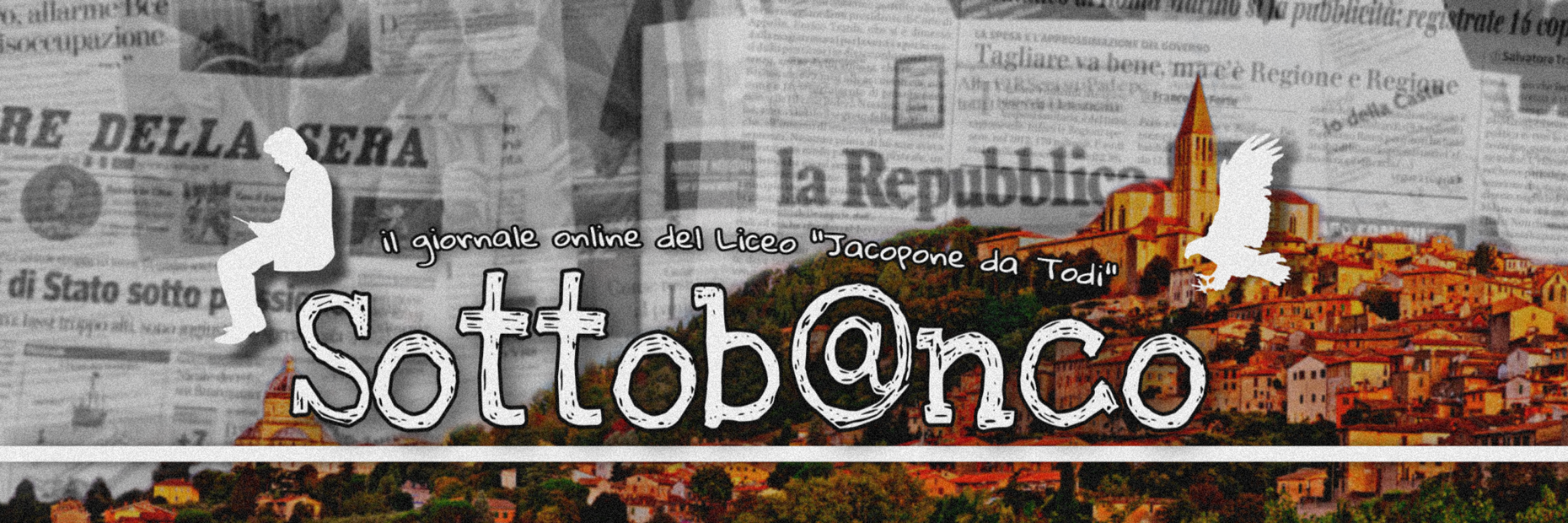

Lascia un commento