
TODI – Il world wide web è la patria della disintermediazione, non ha filtri e dà a chiunque, nel bene e nel male, diritto di parola.
Quando apro il telefono al mattino, mi ritrovo sommersa da un mare di notizie. Alcune mi sembrano importanti, altre sembrano più che altro fatte per attirare l’attenzione. Ma cosa distingue davvero una notizia da un semplice post virale? E come faccio a sapere se quello che leggo è vero?
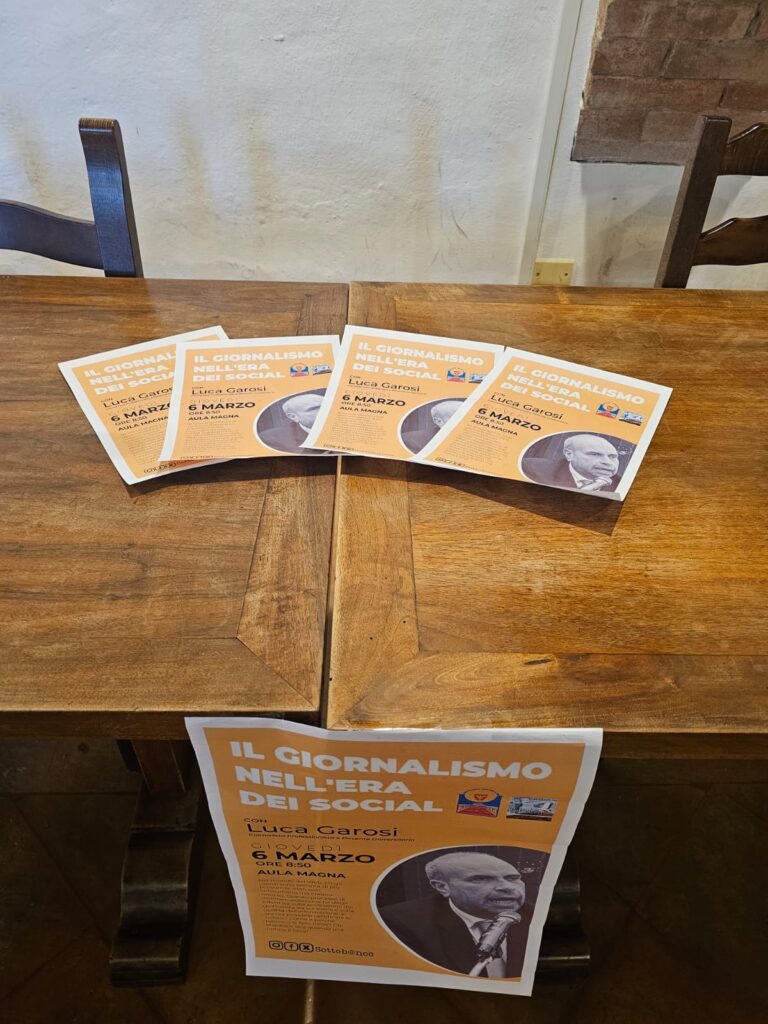
Durante l’incontro con il giornalista Luca Garosi, caporedattore di Rainews, docente universitario e formatore, queste domande hanno finalmente trovato una risposta. L’incontro è stato organizzato dalla nostra redazione nell’ambito del progetto: “Informazione, scuola, territorio”: Garosi non si è limitato a spiegare il giornalismo, ma ci ha fatto riflettere su quanto siamo influenzati dalle informazioni che ci arrivano ogni giorno. E devo ammettere che, fino a quel momento, non mi ero mai fermata a pensarci davvero.
Uno dei momenti che mi ha colpito di più è stato quando Garosi ha parlato della notiziabilità, ovvero di quei criteri che trasformano un avvenimento in notizia, cioè un semplice fatto in un evento di interesse pubblico. Mi ha fatto riflettere su quanto sia selettiva l’informazione che riceviamo.
Per esempio, tutti i telegiornali hanno parlato per mesi della guerra in Ucraina, vista la sua rilevanza, ma oggi – dopo tre anni – a malapena se ne sente parlare. Perché? Perché ormai non è più “interessante” per il pubblico. E che dire dei conflitti in Africa? Non se ne parla quasi mai, perché – diciamoci la verità – non attirano abbastanza l’attenzione. È ingiusto, ma è così che funzionano i media.
Poi c’è la questione della notorietà. Se una persona famosa fa qualcosa, diventa automaticamente una notizia. Fedez e Chiara Ferragni ne sono l’esempio perfetto: qualunque cosa facciano, che sia beneficenza o una semplice crisi di coppia, diventa un argomento di discussione nazionale. Ma se la stessa cosa la facesse una persona qualunque? Nessuno ne parlerebbe.
Mi ha colpito anche il concetto di drammaticità. Più un evento è tragico, più attira attenzione. Una pandemia, una guerra, un disastro naturale: sono questi gli eventi che finiscono in prima pagina. Lo abbiamo visto con il Covid: all’inizio era solo un virus in Cina, poi, quando ha iniziato a coinvolgere tutti noi, è diventato LA NOTIZIA per eccellenza.
Questo mi ha fatto riflettere su quanto il mondo dell’informazione sia guidato dalle emozioni. I giornali, i telegiornali e persino i social media non parlano solo di quello che è importante, ma soprattutto di ciò che suscita forti reazioni. Se una notizia non provoca paura, rabbia o curiosità, difficilmente verrà diffusa su larga scala.
Un altro tema importante è stato quello della disinformazione. Quante volte mi è capitato di leggere una notizia falsa senza accorgermene? O peggio, di condividerla senza verificarla?
Luca Garosi ha spiegato la differenza tra misinformation (quando una notizia falsa viene diffusa senza volerlo) e disinformazione (quando viene diffusa apposta per manipolare le persone). E il problema è che oggi, con il web, è sempre più difficile capire dove finisce l’informazione e dove inizia la propaganda.


Pensiamo ai social: TikTok, Instagram. Siamo bombardati ogni giorno da contenuti virali che sembrano notizie, ma che spesso non lo sono. Video tagliati ad arte, titoli clickbait, meme che mescolano satira e realtà. Come possiamo distinguere il vero dal falso?
Mi ha fatto sorridere pensare a quante bufale mi siano capitate sotto gli occhi senza che me ne rendessi conto. “La NASA ha confermato che oggi sarà la notte più buia degli ultimi 1000 anni”, “Un nuovo studio dice che bere caffè allunga la vita di 50 anni”, “Le piramidi d’Egitto sono state costruite dagli alieni”… Eppure, c’è chi sulle fake news ci costruisce intere carriere. Influencer, pseudo-giornalisti, complottisti: guadagnano grazie alla viralità di notizie sensazionalistiche che spesso non hanno nessuna base reale.
Pensiamo al fenomeno delle teorie del complotto: dal 5G che diffonde il Covid ai rettiliani che governano il mondo. Sono tutte assurdità, eppure c’è sempre qualcuno pronto a crederci. Il motivo? Le fake news sono più intriganti della verità.
Dopo aver ascoltato l’esperto Luca Garosi, mi sono resa conto che tutti noi possiamo fare qualcosa per non cadere nella trappola della disinformazione. Ecco alcuni consigli che cercherò di seguire d’ora in poi:
1. Controllare la fonte – Se una notizia arriva da un sito sconosciuto o da un profilo social senza credibilità, è meglio verificarla prima di condividerla.
2. Evitare di fermarsi ai titoli – Molte fake news usano titoli esagerati e clickbait, ma spesso il contenuto dice tutt’altro.
3. Cercare altre conferme – Se una notizia è vera, probabilmente la troveremo anche su testate affidabili come ANSA, il Corriere, La Repubblica, Rai News.
4. Riconoscere i bias personali – A volte vogliamo credere a una notizia perché conferma la nostra visione del mondo. Ma la verità non è sempre quella che ci fa comodo.
5. Non condividere impulsivamente – Prima di diffondere una notizia, meglio chiedersi: “È vera? È utile? È verificata?”

Se c’è una cosa che ho capito da questo incontro, è che il giornalismo non è solo raccontare i fatti: è scegliere quali fatti raccontare e come farlo. E noi, come pubblico, dobbiamo imparare a non essere spettatori passivi.
D’ora in poi, proverò a essere più critica con quello che leggo. Mi chiederò perché una notizia è in prima pagina e un’altra no. Mi informerò meglio prima di condividere qualcosa. Perché, come ci ha detto Garosi, nell’era dei social non siamo solo consumatori di notizie: siamo anche, nel nostro piccolo, dei comunicatori. E sta a noi scegliere se diffondere informazione o disinformazione.
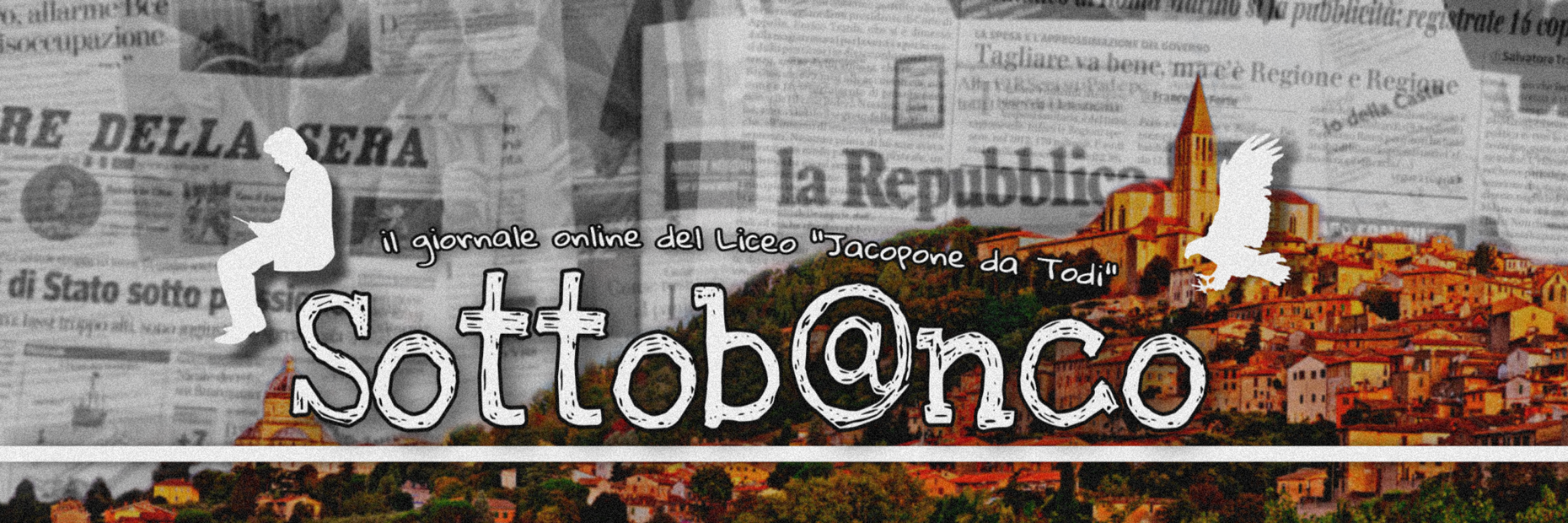

Lascia un commento